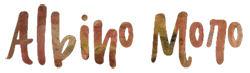Alla ricerca del Silenzio tra boschi e deserto sahariano
In una società a capitalismo avanzato come l’attuale, con abnormi concentrazioni metropolitane dominate dal rumore per il rumore con tanto d’inquinamento acustico, peraltro ampiamente diffuso anche nelle frastornanti città e nei paesi meno urbanizzati, che valore può ancora avere il salvifico e terapeutico Silenzio così congeniale agli esseri umani nella contadina ed artigianale era preindustriale? Che rapporto è poi esistito tra quell’aureo Silenzio ed alcune vicende esemplari dell’arte moderna e contemporanea? Per una serie di convergenze storiche tra questa mostra personale di Albino Moro nella prestigiosa ex navata nel Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, imperniata principalmente su due empatici cicli pittorici e intitolata non a caso Alla ricerca del Silenzio tra boschi e deserto sahariano, possiamo subito chiamare in causa il pittore ottocentesco abruzzese Giuseppe Palizzi e Giorgio De Chirico.
Il primo per esser emigrato nel 1844 in terra francese dove morirà nella sua casa a Marlotte nel 1888, dopo esser divenuto un esponente di spicco del gruppo dei Barbizonniers i quali dipingevano all’aperto nella foresta di Fointainebleau; il secondo, per l’ineguagliabile Silenzio metafisico inglobato nei suoi capolavori. Spendendo alcune righe per Giuseppe, vale qui la pena di ricordare che tra i numerosi amici pittori protagonisti del modernizzato rinnovamento formale e linguistico uscito dalle secche delle imbalsamanti accademie (Corot, Rousseau, Millet…), nonché nella stessa società parigina, era soprannominato “le Sylvain de Fontainebleau” per aver costruito – con la dovuta autorizzazione – una capanna stabile in piena foresta al fine di ripararsi in caso di cattivo tempo (e, perché no, riposarsi): ne fa fede l’ombroso dipinto su tela Pagliara Palizzi. Mentre tanta acqua è nel frattempo passata sotto il ponte delle varie poetiche stilistiche ed espressive succedutesi grazie anche alle numerose rotture epistemologiche di taglio avanguardistico avvenute in ambito non solo pittorico, ci si può legittimamente chiedere: ha ancora senso nella trionfante ed immateriale neo era digitale, usare gli analogici e tradizionale ferri del mestiere, così come continua testardamente a fare Albino Moro da circa sessanta anni? Per di più insistendo nell’effigiare, alla stregua d’un Palizzi, scorci su scorci di boschi “coabitati” sin da bambino nella natia Collelongo? E poi, ancora: che rapporto esistenziale è stato intessuto tra il silente fraseggio di luci ed ombre fitomorfe e le abbacinanti atmosfere sahariane reiteratamente percorse ed incontrate, ad iniziare dagli Anni Ottanta, nei suoi viaggi in Tunisia, Libia, Algeria e Marocco? La risposta sintetica l’affidiamo ad un paio di frasi tratte da alcune delle sue dichiarazioni poetiche riportate in catalogo: «Nei boschi ho avvertito la densità del silenzio, luci e colori filtrano tra verdi, gialli, arancioni rifratti da pennellate di terra […]. Nei deserti ho avvertito il ritmo del silenzio che aleggia tra scenari impregnati di sottili atmosfere di luci e colori, nei mormori delle sabbie in turbinii fra le rocce e in sommità delle dune spinte dal vento».
Come si sarà notato è la parola “Silenzio” a fare da trait d’ union tra i due cicli proposti, con opere spazianti temporalmente dal 2000 al 2024. A colpo d’occhio si noterà subito un diverso approccio formale e cromatico tra gli infittiti, esili quanto vitali tronchi prevalentemente impregnati da colori su colori, prelevati quasi da un’astraente tavolozza kandinskijana mondrianea e le flessuose, arcuate geometrie desertiche.
Il concertante dialogo tra nerastri segni e pigmenti materici ad olio o acrilico, sostanzialmente reinventati alchemicamente dall’artista con l’uso di terre frammischiate a sabbia, ricorrendo a volte anche all’antica tecnica della pittura ad encausto, consente alle sue opere legittimamente collocabili ne “La poetica della rêverie” d’un Gaston Bachelard, di farci rivivere le sue esperienze emotive e visive. Mediate appunto, da quel suo saper “sognare ad occhi aperti” così connaturato nei creativi. L’implicito sfondo metafisico di un tale stato d’animo permette inoltre, ad ognuna di esse, di far affiorare in superficie un cosmo particolare, come scrive lo stesso filosofo francese, riferendosi sì alle “immagini poetiche”, ma perfettamente consono, a nostro modo di vedere, a quelle artistiche: <<Un cosmo particolare si forma attorno a un’immagine particolare da quando un poeta [ma anche un artista n.d.a.] dà all’immagine un destino di grandezza. Il poeta dà all’oggetto reale il suo doppio immaginario, il suo doppio idealizzato. Questo doppio idealizzato è immediatamente idealizzante e è così che un uni- verso nasce da un’immagine in espansione>>.
Già i titoli, quali Interno bosco, In ascolto mormorii ovattati, Luci e colori filtrano, Bosco nero quasi distrutto, Bosco segreto… evocano le continue metamorfosi tra il percepito, il vissuto e la sua trasfigurazione immaginifica. Risolta con una resa frontale e non già prospettica, tanto cara ai precursori Barbizonniers (come può ben costatarsi in un altro dipinto di Giuseppe Palizzi, il Viale nella foresta di Fontainebleau) ed agli stessi impressionisti nei loro plein air “respirati a pieni polmoni”.
Sicché quel Silenzio ricercato, braccato, viene diffuso sull’intero scorcio mediante l’infittito ergersi di tatuati e trasognati alberi su alberi assiepati tra un’inestricabile rete di rami e foglie su sfondi variamente declinati a livello cromatico (ora blu, ora neri, ancora verdi o arancioni ed altre tonalità ancora).
Niente realismo, o peggio, resa veristica in queste tele dove la lingua viva dell’arte sa ben tener conto delle varie lezioni impartite dai Maestri, quale può essere considerato uno dei più rappresentativi pittori abruzzesi della seconda metà del Novecento rispondente al nome di Elio Di Blasio con il cui magistero Albino Moro si è sostanzialmente formato. Né tanto meno ha tralasciato quelle dei vari esponenti di spicco (italiani o stranieri che siano) soprattutto attingendo ad alcuni riattualizzati brani esemplari dell’Informale, dell’Espressionismo Astratto e, marginalmente, del Surrealismo.
Il cortocircuito fisico e psichico tra il Silenzio maturato nei familiari boschi e quello scoperto ex novo tra le dune e rocce sahariane, me lo ha accennato in un telegrafico appunto lo stesso artista: «In uno dei tanti viaggi che ho effettuato in terra d’Africa, un Tuareg, la nostra guida, mi ha dimostrato come “noialtri” non siamo più capaci di ascoltare il silenzio. Da qui è nato il mio desiderio della sua ricerca, perché solo in esso non ci sono ostacoli al pensiero. In questo modo potremmo bandire il grande “chiacchiericcio” [superficialità n.d.a.] presente in ogni settore della nostra vita quotidiana. Ma la cosa più grave è che ciò sta invadendo il campo dell’arte in tutte le sue varie discipline>>.
Sono ancora i metaforici titoli a renderci conto delle varie sfumature trasfuse – dalla ritrovata, rinverginita anima – alla disponibile superficie ricettiva di una carta, una tela, una tavola: Il mio io evapora, Verso il sogno, Discesa da sabbie, A ridosso del vero, La duna verde nel blu…
Scorre adesso un tempo lento e surreale tra quelle rifrangenti cromie sabbiose circoscritte geometricamente da alcune fluidificate masse giocate prevalentemente e non poteva essere altrimenti – con astrattizzati sfondi gialli, marroni, arancio, rossi (ma anche blu) ed inscritte tra un avvallamento e l’altro perimetralmente delimitati da sinuose “presenze”: né antropomorfe, né tanto meno fito o zoomorfe: semplicemente epifaniche ed immanenti.
Sta al sensibile sguardo del fruitore decrittarne o quanto meno condividerne, il misterico senso. Senso di gran lunga meno ermetico in altri due filoni creativi presenti in mostra: i “Libri d’artista” o “Libri-oggetto” che dir si voglia ed i “Gioielli”. Mentre nei primi, variamente assemblati s’impone l’opera tra le “non-pagine” pittoriche, tutte da vedere e ben poco da leggere, nei preziosi “Gioielli” (anelli, bracciali, orecchini, collane) è la riflessa, abbacinante luce sahariana ad irraggiare l’introiettata Bellezza. Quasi a completare, in una rigenerante dimensione ludica, la filigranata firma estetica di Albino Moro.
Antonio Gasbarrini